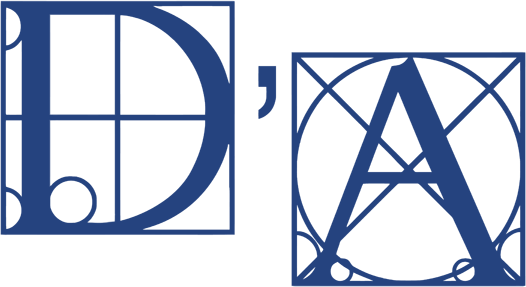
Relazioni industriali, rappresentatività, partecipazione
Elementi per la mappatura di una terra (ancora troppo) incognita
di Marco Biagiotti [*]
 Ci voleva forse l’eco del terremoto francese, quel dust bowl sociale scatenato da un progetto governativo di riforma del diritto del lavoro (c.d. “Loi travail”)[1], per indurci a prestare un po’ di attenzione anche a qualche bradisismo di casa nostra: tanto più potente e gravido di conseguenzialità sul piano culturale, sociale ed economico, quanto meno euristicamente riconoscibile dalle onde sussultorie di piazze in fiamme o servizi pubblici paralizzati a tempo indeterminato.
Ci voleva forse l’eco del terremoto francese, quel dust bowl sociale scatenato da un progetto governativo di riforma del diritto del lavoro (c.d. “Loi travail”)[1], per indurci a prestare un po’ di attenzione anche a qualche bradisismo di casa nostra: tanto più potente e gravido di conseguenzialità sul piano culturale, sociale ed economico, quanto meno euristicamente riconoscibile dalle onde sussultorie di piazze in fiamme o servizi pubblici paralizzati a tempo indeterminato.
Il confronto con le esperienze degli altri è sempre utile, perché aiuta a mettere meglio a fuoco gli avvenimenti, gli scenari e le trasformazioni che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni e dei quali a volte, forse per la mancanza di un sistema di indagine e di monitoraggio adeguato, si stenta a percepire la dimensione e la portata. Come è stato sottolineato da autorevoli osservatori, il progetto francese muove da presupposti che affondano le radici in un contesto di regolazione normativa molto diverso da quello italiano. Ogni paragone diretto con il nostro Jobs Act appare pertanto improprio, se non addirittura fuorviante, ai fini di una comprensione delle logiche di politica del lavoro che ne stanno alla base. Non è questa la sede per entrare nel merito della riforma d’Oltralpe, dei suoi obiettivi e delle sue (in alcuni casi evidenti) criticità, stante anche l’incertezza politica che pesa sul suo destino. Colpisce però come tutto l’impianto riformatore sia pervaso dal tentativo di enfatizzare il ruolo e la funzione della contrattazione di prossimità quale strumento di liberalizzazione delle regole sul lavoro, nell’ambito di una cornice normativa consapevolmente ridefinita con generosi margini di flessibilità proprio per consentirne l’adattamento alle molteplici esigenze delle singole realtà produttive. Questo poderoso sforzo di delega di potestà organizzativa delle condizioni di lavoro nelle imprese (con conseguente mobilizzazione dei confini di un diritto del lavoro sempre più liquido) al livello più decentrato del sistema di relazioni industriali si traduce, nei fatti, in una esaltazione della dimensione aziendale quale unico laboratorio deputato a progettare e realizzare l’adattabilità necessaria a competere sul piano produttivo in uno scenario di globalizzazione ormai dominante e irreversibile. E nel quale, a voler cercare l’esprit de loi, la rimozione del tabù di una possibile condivisione sociale dei rischi d’impresa - implicita nella variabilità congiunturale delle condizioni dei lavoratori in termini di diritti, tutele individuali e qualità della vita – è controbilanciata dalla possibilità di utilizzare gli spazi di autonomia che la stessa legge ora vorrebbe concedere agli accordi aziendali rispetto a ‘vincoli’ e a paletti troppo omologanti fissati dai contratti collettivi nazionali.
Comunque vada a finire il progetto francese – concepito, vale la pena di ripeterlo, in riferimento a modelli giuslavoristici, relazionali e di struttura del sistema produttivo profondamente diversi da quelli italiani – bisogna essere grati al governo e alle opposizioni di quel Paese per averci se non altro indotto ad aprire una riflessione seria anche sulla nostra realtà domestica e sul percorso lungo il quale il sistema italiano delle relazioni industriali sembra essersi avviato da qualche anno a questa parte. Complici anche la perdurante crisi e la notevole frammentazione (con forti divaricazioni territoriali) del nostro tessuto produttivo, la contrattazione collettiva in Italia sta cambiando fisionomia a velocità impressionante, come forse mai era stato dato di vedere in oltre un secolo di storia economica nazionale. Tre sono i fenomeni rilevanti in atto a cui occorre prestare la massima attenzione: la dispersione della rappresentatività, sia a livello di organizzazioni datoriali che sindacali; la crescita di importanza del livello decentrato della contrattazione; la sempre più netta divaricazione fra lavoro pubblico e lavoro privato. In tutti e tre i casi, peraltro, lo spessore della nostra percezione risente della mancanza di un sistema strutturato e istituzionale di rilevazione continua, analisi e interpretazione dei dati, attraverso il quale sia possibile mettere a fuoco in termini oggettivi (si sarebbe tentati di dire: scientifici) una realtà in progress la cui cognizione è affidata, allo stato attuale, ai pamphlet estemporanei di qualche pur rispettabile centro studi o ai bollettini – per lo più ad uso e consumo dei flash delle agenzie di stampa - diramati dai vari istituti pubblici e privati di rilevazione statistica. Ma senza un’adeguata conoscenza dei fenomeni nessun serio intervento di policy contrattuale, per quante risorse pubbliche si sforzi di mettere in campo (e in Italia di risorse pubbliche in tal senso se ne stanno investendo tante!), può sperare di ottenere risultati significativi in termini di crescita della produttività, dei livelli occupazionali, della qualità dei servizi e della democrazia economica.
Cominciamo dal problema delle rappresentanze. Se scorriamo i dati ufficiali sulla contrattazione collettiva nazionale disponibili (liberamente e gratuitamente) sul sito istituzionale del CNEL, l’ente pubblico deputato per legge alla tenuta dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, possiamo notare come negli ultimi anni si sia verificato un significativo incremento del numero degli accordi nazionali ivi depositati, ovviamente – stante il blocco della contrattazione nazionale nel settore pubblico - quasi tutti provenienti dai vari comparti del lavoro privato. Fa una certa impressione constatare come, considerando i soli CCNL classificati come “vigenti” (perché da poco rinnovati, oppure perché in attesa di rinnovo e quindi, di fatto, ancora in vigore), si sia passati dai 580 accordi nazionali censiti nel giugno 2013 ai 780 del giugno 2016, indice di una progressiva frammentazione contrattuale che ha pochi riscontri in ambito europeo. Se poi andiamo a ‘incrociare’ questo dato con quelli che riguardano le delegazioni firmatarie degli accordi nazionali, ci accorgiamo che la maggior parte dei CCNL risulta essere stata sottoscritta da organizzazioni datoriali e sindacali diverse da quelle che, nella vulgata comune, vengono considerate come maggiormente rappresentative. Spesso si tratta di associazioni di recente costituzione, a volte risultanti da fusioni o scissioni di altre preesistenti, la cui rappresentatività in molti casi appare circoscritta al settore produttivo di specifica competenza. Non si tratta, beninteso, di un fenomeno nuovo nel variegato panorama delle relazioni industriali italiane: è nuova, però, l’estensione che esso sta assumendo e che, almeno per quanto concerne la disponibilità di adeguati strumenti di conoscenza e monitoraggio, appare oggi sostanzialmente collocato al di fuori di una effettiva possibilità di misurazione e di controllo.
A prescindere dalla soluzione (legislativa o contrattuale?) che si riuscirà a escogitare per sciogliere quella sorta di mistero eleusino che pare ormai diventata la procedura di accertamento della rappresentatività sindacale ai fini della validità dei contratti collettivi, non è necessario un particolare sforzo di fantasia per immaginare l’utilità, a bocce ferme, di una presenza istituzionale pubblica in grado di implementare e aggiornare un vero e proprio warehouse delle dinamiche della contrattazione collettiva, a partire dalla creazione di un’anagrafe unica dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle organizzazioni rappresentative (datoriali e sindacali) esistenti. Non è curioso che in un Paese come l’Italia, patria del diritto del lavoro, le cui università pubbliche e private pullulano di corsi d’esame e di specializzazione in diritto sindacale e delle relazioni industriali, terra di insigni giuslavoristi e fini contrattualisti con o senza stipendio da parlamentare, non si sia mai sentito il bisogno di dare vita a un sistema unico nazionale di classificazione dei contratti collettivi di lavoro in base al settore produttivo di appartenenza valido per tutti gli enti, le istituzioni nonché i soggetti pubblici e privati che a vario titolo si occupano della materia? Quanto meno, al fine di comprendere esattamente chi firma che cosa e dove, in rappresentanza di quali tipologie di aziende o di lavoratori impegnati in quali specifiche attività di quali settori produttivi.
 Il secondo aspetto riguarda la contrattazione di secondo livello. Che da almeno una quindicina di anni sia in atto, per volontà delle parti sociali, un progressivo spostamento del baricentro della contrattazione dal livello nazionale a quello decentrato, territoriale e aziendale è cosa nota, come testimonia la sequenza dei vari accordi interconfederali (al netto dei tormentati rapporti intercorsi fra i loro protagonisti) susseguitisi fino all’inizio del 2014. Il protocollo sul lavoro e la competitività del 2007[2] ha consacrato l’era dei finanziamenti pubblici alla contrattazione decentrata, prevedendo la riforma (e l’ampliamento) del previgente regime di sgravi contributivi sul salario di produttività per le aziende e i lavoratori del settore privato, a cui poi si sono aggiunti, negli anni successivi, anche gli sgravi fiscali per le quote di salario accessorio erogate in funzione della crescita della produttività secondo criteri stabiliti negli accordi collettivi territoriali e aziendali. Però la svolta decisiva in tal senso – forse anche sull’onda di una cultura europea della prossimità sempre più percepita, a torto o a ragione, come vincente – è arrivata con le norme contenute nell’ultima legge di stabilità[3], che hanno decretato la ripresa, dopo un anno di sospensione, degli incentivi fiscali alla produttività aziendale, ora estesa anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa. Senza volersi addentrare nei tecnicismi di un pacchetto normativo la cui reale efficacia attende di essere verificata a consuntivo, non si può fare a meno di osservare come, per effetto delle novità introdotte quest’anno (ma si dovrebbero considerare anche i numerosi rimandi alla contrattazione integrativa contenuti nel decreto legislativo n. 81/2015 sulla riforma delle tipologie contrattuali), le relazioni industriali a livello aziendale e territoriale si trovino ad essere investite da pesanti responsabilità rispetto a scelte di politica gestionale decisive per le sorti delle aziende, come quelle che riguardano l’innovazione dei processi produttivi, le forme di flessibilità e l’organizzazione della gestione del lavoro.
Il secondo aspetto riguarda la contrattazione di secondo livello. Che da almeno una quindicina di anni sia in atto, per volontà delle parti sociali, un progressivo spostamento del baricentro della contrattazione dal livello nazionale a quello decentrato, territoriale e aziendale è cosa nota, come testimonia la sequenza dei vari accordi interconfederali (al netto dei tormentati rapporti intercorsi fra i loro protagonisti) susseguitisi fino all’inizio del 2014. Il protocollo sul lavoro e la competitività del 2007[2] ha consacrato l’era dei finanziamenti pubblici alla contrattazione decentrata, prevedendo la riforma (e l’ampliamento) del previgente regime di sgravi contributivi sul salario di produttività per le aziende e i lavoratori del settore privato, a cui poi si sono aggiunti, negli anni successivi, anche gli sgravi fiscali per le quote di salario accessorio erogate in funzione della crescita della produttività secondo criteri stabiliti negli accordi collettivi territoriali e aziendali. Però la svolta decisiva in tal senso – forse anche sull’onda di una cultura europea della prossimità sempre più percepita, a torto o a ragione, come vincente – è arrivata con le norme contenute nell’ultima legge di stabilità[3], che hanno decretato la ripresa, dopo un anno di sospensione, degli incentivi fiscali alla produttività aziendale, ora estesa anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa. Senza volersi addentrare nei tecnicismi di un pacchetto normativo la cui reale efficacia attende di essere verificata a consuntivo, non si può fare a meno di osservare come, per effetto delle novità introdotte quest’anno (ma si dovrebbero considerare anche i numerosi rimandi alla contrattazione integrativa contenuti nel decreto legislativo n. 81/2015 sulla riforma delle tipologie contrattuali), le relazioni industriali a livello aziendale e territoriale si trovino ad essere investite da pesanti responsabilità rispetto a scelte di politica gestionale decisive per le sorti delle aziende, come quelle che riguardano l’innovazione dei processi produttivi, le forme di flessibilità e l’organizzazione della gestione del lavoro.
Non occorre grande abilità divinatoria per immaginare che solo attraverso un sistema attento di monitoraggio e analisi degli andamenti della contrattazione di secondo livello nei vari settori produttivi si potranno comprendere i reali risultati di tali innovazioni in termini di crescita della produttività e della competitività delle nostre imprese: problema che, peraltro, chiama in causa una criticità per così dire ‘storica’, legata alla verifica del concreto impatto sul sistema produttivo di incentivi i cui costi ricadono sull’intera collettività. L’esperienza maturata dal 2007 in avanti dimostra che non è sufficiente distribuire a pioggia risorse pubbliche alle aziende in crisi per accrescerne la competitività e la capacità di penetrazione nei mercati globalizzati. Oltre ai soldi, la mano pubblica deve probabilmente mettere in campo qualcos’altro. Una politica del lavoro (di ispirazione magari più renana che francese) che punti a valorizzare il livello negoziale decentrato come momento di reciproca assunzione di responsabilità tra azienda e lavoratori, vincolando benefits e quote di retribuzione al rispetto di parametri condivisi di flessibilità organizzativa, implica – ci si perdoni la franchezza – la capacità politica, sì, ma soprattutto tecnica, da parte dei policy makers, di tenere sotto controllo la situazione. Al di là (molto al di là) dell’ovvia creazione di un big-data informatizzato dei contratti che le aziende sono tenute obbligatoriamente a depositare presso le DTL, occorre una valutazione di impatto che aiuti a comprendere quello che effettivamente accade nelle realtà produttive dove il lavoro si riorganizza in funzione di un incremento della produttività da cui dovrebbe discendere un contributo decisivo alla crescita del PIL nazionale. Occorre analizzare le scelte di cui la contrattazione decentrata è chiamata a farsi carico nei territori e dentro imprese e capire se e da quali fattori (endogeni o esogeni, nazionali o locali, domestici o internazionali) esse siano influenzate e/o condizionate, ed eventualmente in quale misura. Occorre, last but not least, strutturare un processo di counseling istituzionale che sappia cogliere tutte le dinamiche della trasformazione complessa e, per molti aspetti, irreversibile a cui il nostro mercato del lavoro sta andando incontro sotto l’effetto di un alluvione di provvedimenti, spesso mal coordinati, che scaricano sul secondo livello di contrattazione una tensione senza precedenti. Chi governa questo processo? Chi ne mette a sistema gli effetti? Chi possiede il know-how necessario (anche sul piano comparativo internazionale) per suggerire gli eventuali correttivi?
Terza e ultima questione: il divario pubblico-privato. Archiviata la fase storica della ricerca di una omologazione giuridica fra i due sistemi (e, con essa, almeno un paio di decenni di riforme lasciate a metà, compresa quella della contrattazione), stiamo oggi vivendo un periodo caratterizzato da una tendenza del lavoro pubblico a rinchiudersi nel suo universo di leggi speciali, sempre più prono all’autogoverno di una casta inossidabile di sacerdoti del combinato disposto che lo tengono gelosamente segregato da quei processi virtuosi di innovazione organizzativa tipici dei settori più avanzati del mondo del lavoro privato. Di fronte a una pubblica amministrazione incapace di sburocratizzarsi perché schiacciata dal peso di un immobilismo culturale che si riflette in una gestione dissennata e latifondista del capitale umano disponibile, appare sconcertante la banalità del livello a cui ci tiene pervicacemente ancorati il dibattito nazionale sul licenziamento dei ‘furbetti del cartellino’. Da qualche anno a questa parte, una vena di follia autolesionistica sembra aver pervaso le politiche del lavoro pubblico, ormai tutte incentrate sulla guerra di religione fra legulei rispetto all’applicazione o meno del Jobs Act agli statali, quando i livelli occupazionali del settore pubblico sono crollati di 500.000 unità tra il 2006 e il 2015 e l’età media dei ‘superstiti’ supera ampiamente i 53 anni: la più alta d’Europa, ça van sans dire. E quando su qualche giornale si legge che negli uffici giudiziari di Vicenza si registrano carenze d’organico del 67% e che (anche) per questo motivo rischiano di andare in prescrizione i procedimenti a carico degli imputati per il dissesto della Banca Popolare nel cui gorgo sono affondati i risparmi di migliaia di poveri cristi ora sull’orlo del suicidio, ci si rende conto di quanto tempo prezioso sia stato immolato in questo Paese sull’altare delle fasce di reperibilità per le visite fiscali, della mobilità obbligatoria entro i 50 km, degli algoritmi per la valutazione della performance e di altre beate amenità del genere. A forza di spaccare il capello in quattro sulle sentenze della Cassazione per l’articolo 18 agli statali, ci si dimentica che applicare integralmente al pubblico impiego la riforma Fornero del lavoro significa far attraversare a un esercito oltre tre milioni di lavoratori la terra incognita delle norme sui sistemi di partecipazione alla gestione d’impresa (che oggi nel settore privato incominciano a muovere timidamente i primi passi) e sulla rilevazione, classificazione e certificazione delle competenze individuali, vera (e forse unica) chiave di volta per programmare una seria riorganizzazione della nostra macchina amministrativa a partire dalle risorse in house. Ma qualcuno crede davvero che i mitici decreti attuativi della riforma Madia possano appoggiarsi a un sistema di relazioni industriali la cui architettura risale, nella migliore delle ipotesi, a 25 anni fa?
 Oggi un qualsiasi accordo di secondo livello nel settore pubblico sembra un reperto di archeologia sindacale rispetto alla capacità / necessità / volontà di incidere sull'organizzazione del lavoro delle singole unità produttive dove si fa contrattazione e dove si producono i servizi alla cittadinanza. Rispetto alle punte di eccellenza della contrattualistica del lavoro privato, il settore pubblico appare tanto più fermo e arretrato, quanto meno riesce a definire con processi endogeni le condizioni dello scambio sociale fra qualità delle condizioni di vita/lavoro e crescita della produttività. Questo, e non l'assenteismo ingiustificato (problema di dimensioni risibili e, in ogni caso, ovunque risolvibile con normali atti di sana gestione organizzativa), é il vero abisso che divide due mondi sempre più lontani. E visto che in questo periodo si parla tanto di riforma del modello contrattuale (a proposito: un sistema di monitoraggio e valutazione complessiva on the job dell'eventuale riforma resterebbe di pertinenza privata dei soggetti rappresentativi coinvolti? Anche se, per pura coincidenza, andasse a impattare sulla trascurabile questione dell'erga omnes?), tanto vale incominciare ad essere sinceri, innanzitutto con noi stessi, ammettendo con molta chiarezza che qualunque policy per l'efficienza della p.a. sarà sempre destinata a frantumarsi contro la Grande Muraglia del conservatorismo burocratico travestito da performance, come finora è avvenuto, se non si comincerà a introdurre a piene mani anche nel sistema relazionale pubblico elementi reali di flessibilità, responsabilizzazione, partecipazione gestionale e condivisione di scelte rispetto a obiettivi da raggiungere e strumenti organizzativi da mettere in campo.
Oggi un qualsiasi accordo di secondo livello nel settore pubblico sembra un reperto di archeologia sindacale rispetto alla capacità / necessità / volontà di incidere sull'organizzazione del lavoro delle singole unità produttive dove si fa contrattazione e dove si producono i servizi alla cittadinanza. Rispetto alle punte di eccellenza della contrattualistica del lavoro privato, il settore pubblico appare tanto più fermo e arretrato, quanto meno riesce a definire con processi endogeni le condizioni dello scambio sociale fra qualità delle condizioni di vita/lavoro e crescita della produttività. Questo, e non l'assenteismo ingiustificato (problema di dimensioni risibili e, in ogni caso, ovunque risolvibile con normali atti di sana gestione organizzativa), é il vero abisso che divide due mondi sempre più lontani. E visto che in questo periodo si parla tanto di riforma del modello contrattuale (a proposito: un sistema di monitoraggio e valutazione complessiva on the job dell'eventuale riforma resterebbe di pertinenza privata dei soggetti rappresentativi coinvolti? Anche se, per pura coincidenza, andasse a impattare sulla trascurabile questione dell'erga omnes?), tanto vale incominciare ad essere sinceri, innanzitutto con noi stessi, ammettendo con molta chiarezza che qualunque policy per l'efficienza della p.a. sarà sempre destinata a frantumarsi contro la Grande Muraglia del conservatorismo burocratico travestito da performance, come finora è avvenuto, se non si comincerà a introdurre a piene mani anche nel sistema relazionale pubblico elementi reali di flessibilità, responsabilizzazione, partecipazione gestionale e condivisione di scelte rispetto a obiettivi da raggiungere e strumenti organizzativi da mettere in campo.
E qui il nostro ragionamento si arresta, almeno per ora: perché, prima ancora che di una mappa con il disegno del territorio da esplorare, quello di cui avremmo bisogno con assoluta ed estrema urgenza per proseguire é una matita e un foglio di carta su cui incominciare a tracciare le coordinate geografiche con i gradi di latitudine e longitudine. Un foglio possibilmente pulito, però, senza traccia di scarabocchi ideologici stampati in filigrana. ![]()
Note
[1] Il disegno di legge firmato dalla ministra del lavoro El Kohmri è stato annunciato alla fine di febbraio e presentato il 24 marzo scorso.
[2] Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibile del 23 luglio 2007, www.cnel.it / archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro / accordi tra governo e parti sociali.
[3] Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 182.
[*] Marco Biagiotti, già dipendente del Ministero del Lavoro, lavora presso il CNEL. In passato ha collaborato alla realizzazione, per la UIL Pubblica Amministrazione, della collana di volumi “Lavoro e contratti nel pubblico impiego”. Dal 1996 al 2006 é stato responsabile del periodico di informazione e cultura sindacale “Il Corriere del Lavoro”.



Seguiteci su Facebook