Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona
Anno XIII - n° 70
Luglio/Agosto 2025
Il lavoro in carcere: un diritto fondamentale per il reinserimento e la dignità
di Denise Amerini [*]
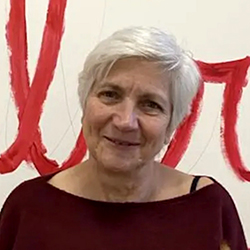
Il lavoro, elemento cardine del reinserimento per le persone ristrette, è diritto fondamentale e valore fondante, identitario, della nostra Repubblica, come sancito dall’articolo 1 della Costituzione, la quale, inoltre, all’art. 4, stabilisce che “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro” e, all’art. 35, che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”.
 La Costituzione non fa differenza fra lavoratori detenuti e no: tutela il lavoro in tutte le sue forme. Il lavoro, per le persone ristrette, ha un valore in più, perché oltre ad essere una fonte, seppur limitata, di reddito, può consentire l’emancipazione dai circuiti dell’illegalità, delle diseguaglianze, del disagio, della povertà, dell’esclusione, e promuovere il reinserimento sociale.
La Costituzione non fa differenza fra lavoratori detenuti e no: tutela il lavoro in tutte le sue forme. Il lavoro, per le persone ristrette, ha un valore in più, perché oltre ad essere una fonte, seppur limitata, di reddito, può consentire l’emancipazione dai circuiti dell’illegalità, delle diseguaglianze, del disagio, della povertà, dell’esclusione, e promuovere il reinserimento sociale.
Il lavoro in carcere deve quindi perdere ogni carattere afflittivo, di sfruttamento, di minore riconoscimento rispetto al lavoro delle persone “libere”, stabilire pari dignità e pari diritti, per quanto riguarda orario, ferie, contributi, salario. Ancora oggi, però, permangono differenze importanti, a partire dalla retribuzione per coloro che svolgono attività alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria (e sono la stragrande maggioranza dell’esiguo numero dei detenuti che lavorano), stabilita nella misura di due terzi di quella prevista dal contratto collettivo di riferimento.
Quest’anno ricorrono i 50 anni dell’Ordinamento Penitenziario, la legge 354 del 1975. E proprio a distanza di tanti anni da quella legge, abbiamo, oggi più di sempre, la necessità di un grande lavoro culturale sul senso e la funzione delle pene (è la nostra Costituzione, non a caso, che usa il plurale) a fronte di un panpenalismo, di un giustizialismo imperante, che ha caratterizzato i provvedimenti di questo Governo, che informa il sentire comune, e che vorrebbe riportare a un significato emendativo, retributivo, risarcitorio il lavoro delle persone ristrette. Come ha affermato Mauro Palma, già Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, si è in carcere perché si è puniti, non per essere puniti. E se le pene devono davvero e finalmente perdere ogni carattere afflittivo, che non sia quello della limitazione della libertà personale, anche il lavoro delle persone ristrette non può configurarsi come un semplice scambio tra prestazione lavorativa e rieducazione.
Come sostiene Giuseppe Caputo in molti suoi lavori, il lavoro finalizzato al trattamento rieducativo altera la natura del rapporto di lavoro, poiché si colloca in un confine sfumato fra la concezione afflittiva attribuitagli dal Codice Rocco e una concezione correzionalistica che ancor oggi si può leggere nell’Ordinamento Penitenziario (OP).
Troppo spesso il lavoro delle persone ristrette è tuttora visto come misura accessoria della pena, come poco qualificato e poco produttivo e il lavoro svolto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria non garantisce nessun percorso in qualche misura professionalizzante, spendibile all’esterno, mentre, come scrive Francesca Malzani, può essere fondamentale veicolo di reinserimento e di lotta alla recidiva, se integrato in un costrutto progettuale di presidio di dignità della persona.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è intervenuta su questo tipo di approccio, accogliendo le osservazioni e le proposte delle European Prison Rules del 2006, che chiedono il superamento del modello correzionale e l’implementazione di tutti i diritti compatibili con la detenzione: per quanto riguarda il lavoro, quindi, il diritto ad una giusta retribuzione, alla previdenza, a salute e sicurezza.
 Le Mandela Rules, nel 2015, hanno superato il concetto di obbligatorietà, stabilendo che a ogni persona ristretta devono essere offerte opportunità di lavoro: lavoro non come strumento di correzione ma come attività che devono essere proposte e accettate per favorire e facilitare il reinserimento a fine pena.
Le Mandela Rules, nel 2015, hanno superato il concetto di obbligatorietà, stabilendo che a ogni persona ristretta devono essere offerte opportunità di lavoro: lavoro non come strumento di correzione ma come attività che devono essere proposte e accettate per favorire e facilitare il reinserimento a fine pena.
Nel nostro Paese non si è, però, realizzata una completa equiparazione normativa del lavoro penitenziario al lavoro libero, nonostante l’art. 20 OP stabilisca che l’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera, al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative, per agevolarne il reinserimento sociale.
Sull’Ordinamento Penitenziario, dopo alcuni provvedimenti che si sono succeduti negli anni – come ad esempio il regolamento di esecuzione (DPR 230/2000) – sono intervenuti i decreti legislativi 123 e 124 del 2018, che hanno recepito una parte, per quanto piccola, delle proposte elaborate dagli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, iniziativa promossa dall’allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando, che avevano visto al lavoro 18 tavoli tematici, al fine di elaborare proposte per una riforma complessiva dell’ordinamento penitenziario, con l’obiettivo di migliorare tutto il sistema dell’esecuzione penale, rendendolo conforme ai principi costituzionali e alle norme internazionali.
In particolare, il decreto legislativo 124, al capo secondo, interviene sul lavoro penitenziario, riscrivendo l’art. 20 OP, eliminando ogni previsione di obbligatorietà del lavoro penitenziario, chiaramente in contrasto con il principio del libero consenso al trattamento, stabilendo che la durata delle prestazioni non può superare i limiti stabiliti dalle leggi, sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito, la tutela assicurativa e previdenziale e, soprattutto, intervenendo sulla disciplina della remunerazione (finalmente non più ‘mercede’), stabilendone la quantificazione in una misura fissa, pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.
Questo riguarda, ovviamente, il lavoro svolto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, perché per le persone ristrette alle dipendenze di aziende esterne si applica integralmente il contratto di riferimento, anche per quanto riguarda la retribuzione. Ma se il lavoro delle persone ristrette deve essere equiparabile, anche per quanto riguarda le tutele, a quello svolto fuori dal carcere, al lavoro delle persone libere, senza distinzioni tra lavoratori liberi e detenuti, fra dipendenti dell’Amministrazione o di datori di lavoro esterni, la riduzione di un terzo del salario non trova alcun sostegno, e non può trovarne neanche nella motivazione che tale importo serve a contribuire al mantenimento presso l’istituto penitenziario. Senza considerare il fatto che, comunque, i detenuti sono tenuti a rimborsare parte delle spese per il loro mantenimento in carcere, vitto e alloggio, secondo quanto stabilito dall’art. 2 OP.
Il decreto 124/2018 interviene anche sul lavoro di pubblica utilità, istituto previsto dal DL 78 del 2013, quale modalità di trattamento penitenziario. Molte sono le perplessità che da più parti si sono evidenziate su questo istituto, poiché, come ben rileva sempre Francesca Malzani, stride con il dettato dell’art. 36 Cost., con il diritto per i lavoratori all’equa retribuzione. Non si tratta infatti del lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva alla detenzione, ma della destinazione di detenuti a mansioni ed impieghi continuativi e strutturati, quali, ad esempio, la manutenzione del verde pubblico, spesso a fianco di dipendenti di imprese esterne, spesso sottraendo lavoro retribuito e tutelato a imprese che impiegano personale in situazioni di svantaggio, non di rado cooperative sociali che occupano detenuti o ex detenuti, creando forme di dumping legate alla minore onerosità della prestazione.
In questo percorso si è recentemente inserito il CNEL, con l’istituzione del Segretariato permanente per l’inclusione economica, sociale, lavorativa delle persone private della libertà personale. I lavori di questo organismo hanno contribuito all’elaborazione di un disegno di legge, approvato nell’Assemblea del 29 maggio 2024, recante “Disposizioni per l’inclusione lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o restrittivi della libertà personale emanate dall’autorità giudiziaria”. Tale disegno di legge giunge dopo anni in cui da più parti, associazioni, giuristi, organizzazioni della società civile, compresa la CGIL, con prese di posizione ed iniziative pubbliche, hanno chiesto con forza di intervenire per normare il lavoro penitenziario, affinché non scontasse più differenze con il lavoro libero. Come si legge nel comunicato stampa diramato a seguito di quell’Assemblea, il disegno di legge vuole rivisitare – come fortemente richiesto dalla CGIL – l’attuale quadro normativo e regolamentare in materia di ordinamento penitenziario. In particolare, l’art. 1 interviene sull’art. 20 OP, stabilendo che ai “detenuti e agli internati si applica il contratto collettivo nazionale territoriale e aziendale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dai datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicato nel settore produttivo e strettamente connesso con l'attività svolta”. Si prevede, inoltre, al comma b), che venga superata la retribuzione pari a due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi, modificando il testo dell’art. 22, con la dicitura “in misura pari al trattamento economico e normativo complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale territoriale e aziendale stipulato dalle associazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, recependo le richieste e le proposte avanzate unitariamente durante i lavori del segretariato.
 Questo risponde all’obiettivo di una piena e completa equiparazione del lavoro delle persone ristrette a quello delle persone libere, del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria a quello svolto per altri soggetti datoriali.
Questo risponde all’obiettivo di una piena e completa equiparazione del lavoro delle persone ristrette a quello delle persone libere, del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria a quello svolto per altri soggetti datoriali.
Nel disegno di legge non viene fatto alcun riferimento al Lavoro di Pubblica Utilità, previsto dal decreto 124/2018. Vogliamo pensare che questo sia un passo verso il suo definitivo superamento, proprio in ragione di quanto scritto nell’articolo 1.
Un ragionamento particolare merita infine l’istituto della Naspi. L’art. 20 dell’ordinamento penitenziario aveva stabilito l’accesso agli ammortizzatori sociali previsti per ogni lavoratore anche per i detenuti lavoratori, riconoscendo il diritto alla previdenza sociale. La Naspi è stata disciplinata dal decreto legislativo 22 del 2015: le disposizioni di questo decreto non escludono né direttamente né indirettamente il lavoro carcerario dall'assicurazione. I rapporti di lavoro delle persone ristrette, sia alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria che, ovviamente, di imprese esterne, sono assoggettati alla contribuzione, i requisiti contributivi previsti dalla norma sono del tutto compatibili con il lavoro penitenziario. Anche la previsione dell’immediata disponibilità “allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”, non realizzabile per persone private della libertà personale, è superata da quanto previsto dalle previgenti norme sul collocamento, che esoneravano i detenuti da tale requisito. Ancora oggi, però, i lavoratori che hanno svolto prestazioni lavorative durante la detenzione si trovano costretti ad agire vertenzialità nei confronti di INPS per vedere riconosciuto il loro diritto.
La giurisprudenza costituzionale e la Corte EDU hanno ripetutamente affermato la formale equipollenza del lavoro penitenziario al lavoro libero: non possiamo accettare che vengano poi strumentalmente introdotte differenziazioni sostanziali. Se il lavoro in carcere deve finalmente perdere ogni caratteristica afflittiva deve avere le stesse tutele e le stesse garanzie del lavoro fuori, anche per quanto riguarda l’accesso agli ammortizzatori. Non può essere un obbligo, è un diritto/dovere: la norma recita che l’amministrazione è tenuta a garantirlo, eppure sappiamo quanto ancora siamo distanti dall’obiettivo della garanzia di un lavoro dignitoso, riconosciuto, tutelato per le persone ristrette, visto che ad oggi lavora solo 1/3 dei detenuti, troppo spesso per poche ore al giorno, per pochi giorni durante la settimana, in maniera discontinua durante l’anno. E di questi solo un 3% circa è alle dipendenze di datori di lavoro esterni.
In questo senso rivestono importanza gli articoli del disegno di legge Cnel che estendono i benefici della legge Smuraglia, prevedendone un prolungamento temporale e incentivandone una applicazione diffusa sul territorio, che potenziano le commissioni già previste dalle norme, anche ai fini della certificazione delle competenze formative e professionali delle persone detenute, che introducono la possibilità di convenzioni e protocolli di intesa con enti di patronato e centri di assistenza fiscale delle organizzazioni sindacali e degli enti del terzo settore, al fine di assicurare l’erogazione di servizi di assistenza all’espletamento delle pratiche per prestazioni assistenziali e previdenziali e servizi di politiche attive del lavoro.
 Al di là delle intenzioni, è comunque questo un percorso tutto da verificare, sul quale ad oggi non abbiamo concreti riscontri, e non possiamo sottacere il fatto che, se non si interviene a monte, sulla condizione ormai fuori da ogni limite delle carceri nel nostro Paese, sarà difficile che provvedimenti del tutto condivisibili, nati con le migliori intenzioni, possano avere un risultato significativo e concreto. Siamo in una situazione in cui il sovraffollamento ha superato il 133%, con punte in alcuni istituti che arrivano a sfiorare il 200%. Celle insalubri, spesso infestate da parassiti, dove non vengono garantiti gli standard minimi dí abitabilità, servizi igienici inadeguati, assenza di acqua calda, spazi inadeguati che impediscono lo svolgimento di tutte quelle attività finalizzate alla socialità, e i suicidi che già si contano in 41 dall’inizio dell’anno… Siamo ancora una volta nelle condizioni in cui si è trovato il nostro Paese quando, con la sentenza Torreggiani del gennaio 2013, ha subito la condanna della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo per violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, che ha imposto allo Stato l’adozione di misure in grado di risolvere il problema del sovraffollamento e di garantire i diritti umani dei detenuti.
Al di là delle intenzioni, è comunque questo un percorso tutto da verificare, sul quale ad oggi non abbiamo concreti riscontri, e non possiamo sottacere il fatto che, se non si interviene a monte, sulla condizione ormai fuori da ogni limite delle carceri nel nostro Paese, sarà difficile che provvedimenti del tutto condivisibili, nati con le migliori intenzioni, possano avere un risultato significativo e concreto. Siamo in una situazione in cui il sovraffollamento ha superato il 133%, con punte in alcuni istituti che arrivano a sfiorare il 200%. Celle insalubri, spesso infestate da parassiti, dove non vengono garantiti gli standard minimi dí abitabilità, servizi igienici inadeguati, assenza di acqua calda, spazi inadeguati che impediscono lo svolgimento di tutte quelle attività finalizzate alla socialità, e i suicidi che già si contano in 41 dall’inizio dell’anno… Siamo ancora una volta nelle condizioni in cui si è trovato il nostro Paese quando, con la sentenza Torreggiani del gennaio 2013, ha subito la condanna della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo per violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, che ha imposto allo Stato l’adozione di misure in grado di risolvere il problema del sovraffollamento e di garantire i diritti umani dei detenuti.
Servono misure deflattive vere ed incisive, altrimenti qualsiasi provvedimento si scontrerà con una realtà che ne impedirà la compiuta applicazione. Se riusciremo, invece, in questo, ne trarrà vantaggio tutta la società: misure alternative, formazione e, soprattutto, il lavoro sono in grado di abbattere la recidiva, di restituire al mondo fuori persone che possono inserirsi in maniera dignitosa nella società. ![]()
[*] Responsabile Dipendenze e Carcere CGIL Nazionale




Seguiteci su Facebook