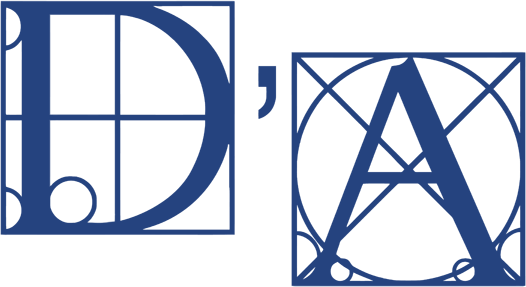
Ritorno al futuro
Il nuovo capitolo dell’eterno duello tra legge e contratto nel rapporto di lavoro pubblico
di Marco Biagiotti [*]
 “I lavoratori sono il motore del buon funzionamento della pubblica amministrazione: da loro, dall’organizzazione del lavoro, nonché dall’organizzazione delle singole amministrazioni, dipendono principalmente i tempi di risposta e la qualità dei servizi che vengono offerti ai cittadini e alle imprese”.
“I lavoratori sono il motore del buon funzionamento della pubblica amministrazione: da loro, dall’organizzazione del lavoro, nonché dall’organizzazione delle singole amministrazioni, dipendono principalmente i tempi di risposta e la qualità dei servizi che vengono offerti ai cittadini e alle imprese”.
Sembra quasi l’epigrafe di un manifesto sindacale d’altri tempi l’incipit dell’intesa politica che le confederazioni CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto il 30 novembre scorso con il Governo pre-referendario, rappresentato dalla Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, e dal sottosegretario Angelo Rughetti, sul rinnovo dei contratti collettivi del pubblico impiego scaduti il 31 dicembre 2009. Al netto dei possibili riflessi che l’evoluzione del quadro politico potrà avere sulle condizioni di applicabilità dell’accordo, il suo tratto più caratterizzante risiede nella netta scelta di “discontinuità” che le parti firmatarie hanno voluto condividere per quanto riguarda l’approccio ai temi e ai problemi del complicato mondo del lavoro pubblico. Un approccio che, in analogia con le tendenze più innovative già da tempo in atto nel settore privato, prende le mosse innanzitutto da una decisa e consapevole implementazione del vasto arsenale di potenzialità attivabili attraverso lo strumento delle relazioni sindacali, in tutte le sue articolazioni.
Certo non casualmente, proprio attorno al problema della ridefinizione del modello di relazioni sindacali si circoscrive il perimetro di interesse del capitolo di esordio dell’intesa, articolato in tre differenti passaggi programmatici che alludono, pur se da distinte prospettive, all’annosa e mai risolta dialettica tra prerogative di legge e spazio di manovra dei contratti. A ben guardare, il cuore ‘politico’ del documento non sta tanto nella previsione di un coinvolgimento attivo e responsabile dei lavoratori nel processo di riforma della p.a (riedizione in chiave 4.0 di un motivo ricorrente negli accordi nazionali dell’era contrattualistica pre-brunettiana) e, tanto meno, nell’impegno del governo a trovare le risorse per corrispondere i famosi 85 euro di aumento medio a regime, sui quali comunque ritorneremo più avanti. Il vero nodo focale dell’accordo è quello che riguarda il tema degli ambiti di competenza della contrattazione rispetto alle condizioni che regolano lo svolgimento del rapporto di lavoro pubblico: dolorosa ferita aperta nel sistema relazionale della p.a. sin da quando il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 era intervenuto modificando pesantemente l’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: una prima modifica capovolgeva lo spirito di delegificazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti scaturito dalle riforme degli anni ’90 (e assorbito, nei vari comparti, dai contratti collettivi di natura privatistica che ne erano derivati), inserendo nel comma 2 la previsione che “eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”; una seconda modifica, definita con il nuovo comma 3-bis, sanciva l’applicabilità degli articoli 1339 e 1419-secondo comma del codice civile “in caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva”[1].
Da allora, l’equilibrio fra legge e contratto nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione si è spezzato a favore di una netta prevalenza della prima sul secondo[2]. Dopo un quindicennio di concezione all-bargaining del rapporto di lavoro, per effetto della quale era stato possibile sviluppare nel settore pubblico un sistema relazionale articolato ed evoluto[3], l’ingresso del nostro Paese nel tunnel della crisi economica ha indotto una sorta di ripensamento culturale, spingendo Governi e Parlamenti di ogni tendenza e colore politico a impegnarsi in una sorta di corsa alla rilegificazione delle regole in materia di pubblico impiego. Per almeno sette-otto anni si è assistito a un proliferare di norme e leggi speciali, valide solo per il settore pubblico, che hanno finito per riproporre, se possibile ampliandola, quella divaricazione tra lavoro pubblico e lavoro privato che le riforme degli anni ’90 avevano cercato, almeno in parte, di colmare. Eppure la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese non se ne è avvantaggiata, come dimostra la percezione ancora diffusa di inefficienza della nostra macchina amministrativa, che continua ad alimentare il dibattito intorno alla mai sopita necessità di mettere mano a nuove e profonde riforme, nonché all’incidenza che esse potrebbero avere sulle prospettive di crescita economica del Paese. D’altro canto, gli scarsi progressi ottenuti sul fronte dell’innovazione hanno finito per ingessare la p.a. e il suo sterminato patrimonio di risorse umane nel recinto asfittico di un burocratismo autoreferenziale di cui, oggi, si scontano le negative conseguenze in termini di capacità di rispondere agli stimoli del cambiamento adeguando e/o riprogettando in modo endogeno i propri processi organizzativi. Ed è singolare che tutto questo avvenga proprio nel momento storico in cui il nostro sistema produttivo, alle soglie della quarta rivoluzione industriale, raccoglie la sfida più importante per il proprio futuro giocando la carta della condivisione responsabile di scelte, obiettivi e strumenti, attraverso un modello relazionale sempre più orientato alla partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione d’impresa e nella elaborazione dei criteri di distribuzione della ricchezza prodotta.
Non c’è dunque da sorprendersi se l’accordo del 30 novembre ha posto il tema delle relazioni industriali al vertice della propria piramide di interesse, declinandone con attenzione gli ambiti e le prospettive di sviluppo. Il primo punto ad essere affrontato è quello della revisione dell’apparato normativo esistente, con un neanche troppo sottinteso richiamo all’impianto regolatorio definito nei Titoli III e IV del decreto legislativo n. 150/2009. Ad essere chiamate in causa, in questo caso, sono soprattutto (anche se non esclusivamente) le disposizioni che disciplinano il funzionamento del sistema premiale e i criteri di distribuzione del salario accessorio in rapporto alla produttività individuale e collettiva[4]. Nel merito, si conviene sulla necessità di mettere mano ad un “intervento legislativo” finalizzato alla profonda revisione degli “ambiti di competenza, rispettivamente, della legge e del contratto”, con conseguente riconoscimento della “fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, nonché degli aspetti organizzativi a questi direttamente pertinenti”. L’intervento legislativo “volto a promuovere il riequilibrio a favore della contrattazione del rapporto tra le fonti che disciplinano il rapporto di lavoro per i dipendenti di tutti i settori, aree e comparti di contrattazione” del settore pubblico andrebbe realizzato, da parte del Governo, nell’ambito dell’esercizio della delega di cui all’art. 17 della legge 124/2015 (c.d. “riforma Madia” della p.a.) concernente il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: delega i cui termini scadranno nel febbraio del 2017.
 A seguire, l’intesa del 30 novembre sancisce l’impegno delle parti ad individuare, nell’ambito dei contratti collettivi (non solo nazionali), “ulteriori ambiti di esercizio della partecipazione sindacale” in grado di favorire lo sviluppo di “nuove e piene” relazioni industriali: autentica rivoluzione copernicana, si direbbe, in un contesto dove troppo spesso i momenti partecipativi evaporano in una dimensione di sterile ritualismo, del tutto priva di quegli apporti di originalità che caratterizzano la migliore contrattualistica del lavoro privato in questi ultimi anni e che investono aspetti quali le flessibilità organizzative legate ad incrementi misurabili della produttività, l’innovazione dei processi, l’introduzione di strumenti di work-life balance, l’analisi condivisa delle strategie aziendali, e via dicendo. Forse proprio in questo passaggio si coglie maggiormente lo sforzo di superare, nel settore pubblico, l’impasse che da circa un decennio tiene inchiodate le relazioni sindacali sul bagnasciuga di un burocratismo ragionieristico imposto dal dogma del contenimento della spesa pubblica e che – giusto per fare un esempio – ancora oggi annovera fra le passività a carico del bilancio statale persino il tempo di svolgimento delle trattative per la contrattazione integrativa, se i dipendenti dell’ufficio vi partecipano durante l’orario di servizio nella veste di dirigenti sindacali. Comunque, l’intesa evita di avventurarsi in tecnicismi o di incanalare in modo troppo schematico la riflessione su quali potrebbero essere i possibili “ulteriori ambiti di esercizio della partecipazione sindacale”, con ciò implicitamente conferendo ampio spazio discrezionale al confronto di merito che accompagnerà la stesura dei nuovi contratti[5].
A seguire, l’intesa del 30 novembre sancisce l’impegno delle parti ad individuare, nell’ambito dei contratti collettivi (non solo nazionali), “ulteriori ambiti di esercizio della partecipazione sindacale” in grado di favorire lo sviluppo di “nuove e piene” relazioni industriali: autentica rivoluzione copernicana, si direbbe, in un contesto dove troppo spesso i momenti partecipativi evaporano in una dimensione di sterile ritualismo, del tutto priva di quegli apporti di originalità che caratterizzano la migliore contrattualistica del lavoro privato in questi ultimi anni e che investono aspetti quali le flessibilità organizzative legate ad incrementi misurabili della produttività, l’innovazione dei processi, l’introduzione di strumenti di work-life balance, l’analisi condivisa delle strategie aziendali, e via dicendo. Forse proprio in questo passaggio si coglie maggiormente lo sforzo di superare, nel settore pubblico, l’impasse che da circa un decennio tiene inchiodate le relazioni sindacali sul bagnasciuga di un burocratismo ragionieristico imposto dal dogma del contenimento della spesa pubblica e che – giusto per fare un esempio – ancora oggi annovera fra le passività a carico del bilancio statale persino il tempo di svolgimento delle trattative per la contrattazione integrativa, se i dipendenti dell’ufficio vi partecipano durante l’orario di servizio nella veste di dirigenti sindacali. Comunque, l’intesa evita di avventurarsi in tecnicismi o di incanalare in modo troppo schematico la riflessione su quali potrebbero essere i possibili “ulteriori ambiti di esercizio della partecipazione sindacale”, con ciò implicitamente conferendo ampio spazio discrezionale al confronto di merito che accompagnerà la stesura dei nuovi contratti[5].
È piuttosto il terzo e ultimo punto, fra quelli dedicati alle relazioni sindacali, ad offrire la novità più interessante rispetto alla definizione della cornice giuridica di riferimento per lo sviluppo delle politiche contrattuali nel settore pubblico, con l’impegno del Governo a riformare il comma 3-ter dell’articolo 40 del d.lgs. 165/2001, riguardante la possibilità per le amministrazioni di procedere con “atto unilaterale” in caso di mancato raggiungimento dell’accordo con le organizzazioni sindacali[6]. Si tratta di una disposizione introdotta nell’ambito del pacchetto riformatore contenuto nel d.lgs. 150/2009 e che, sino a questo momento, non risulta essere stata utilizzata in modo particolarmente estensivo nei vari comparti della p.a.; ma che contiene una indubbia potenzialità deterrente nei confronti del sistema relazionale proprio in virtù dell’ampia discrezionalità che essa consegna alla parte datoriale pubblica. La modifica preannunciata ha soprattutto l’obiettivo di circoscrivere l’utilizzo dell’atto unilaterale ad un numero ristretto di casi che potremmo definire di ‘necessità’; quelli, cioè, nei quali lo stallo nelle trattative (e saranno comunque i contratti collettivi a stabilirne la durata) possa determinare un reale “pregiudizio economico all’azione amministrativa”.
A dispetto del basso profilo ostentato nel titolo, la “Parte normativa” assembla un’ambiziosa lista di impegni reciproci che il Governo e le Organizzazioni sindacali firmatarie dichiarano di voler assumere in vista dell’apertura dei tavoli negoziali per i rinnovi dei CCNL. Si tratta di misure demandate a specifici interventi legislativi che, presumibilmente, dovranno trovare spazio nel preannunciato ‘nuovo testo unico’ del pubblico impiego, attuativo della delega contenuta nell’art. 17 della legge n. 124/2015, il cui decreto attuativo - come già accennato - è atteso entro febbraio 2017, crisi politica permettendo. Al primo posto viene indicata l’individuazione di nuovi sistemi di valutazione della performance, con conseguente misurazione e valorizzazione dei differenti apporti individuali: il che presuppone la necessità di una profonda revisione dei meccanismi definiti nel Titolo II del d.lgs. 150/2009. Come secondo obiettivo, poi, si fa riferimento all’adozione di “specifiche misure” in grado di perseguire un più stretto legame di interdipendenza fra “miglioramento delle condizioni di lavoro” e obiettivi di “produttività per il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini in termini di qualità e tempi certi nell’erogazione dei servizi”[7], ivi incluse le (per ora non meglio identificate) “misure contrattuali” finalizzate ad incentivare “più elevati tassi medi di presenza” nell’ambito degli indicatori di efficacia delle prestazioni delle amministrazioni e di produttività collettiva.
Particolarmente stimolante, a nostro avviso, è il passaggio – peraltro, curiosamente trascurato dai commenti degli osservatori specializzati – sull’importanza dell’“ambiente organizzativo e del lavoro” e sulla sua implicita connessione con il manifestarsi di criticità divenute (o ritenute) ormai emblematiche del contesto pubblico, quali disaffezione e demotivazione, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di qualità dell’output e di comportamenti non irreprensibili da parte di alcuni dipendenti. Proprio prendendo spunto dall’esplicito riferimento ai “fenomeni anomali di assenteismo”, piace intravedere in questo paragrafo l’inizio di un approccio finalmente serio e non banalizzante a problemi (false timbrature, scarsa propensione al cambiamento e simili) riconducibili essenzialmente a situazioni di pessima organizzazione del lavoro nelle strutture dove se ne registra il verificarsi in forme non occasionali o estemporanee. Al riguardo, è davvero auspicabile che la prevista introduzione di “strumenti di monitoraggio delle carenze e delle necessità di riorganizzazione sul fronte del superamento della spesa improduttiva, del precariato, della migliore conciliazione vita-lavoro, della flessibilità oraria (…), della formazione continua” fornisca la spinta necessaria a ricercare soluzioni che sappiano andare oltre il mero rafforzamento di un apparato repressivo e sanzionatorio già sin troppo strutturato, allargando l’orizzonte d’indagine (e di intervento, sia normativo che contrattuale) al tema dell’obsolescenza e dell’autoreferenzialità dei processi organizzativi che sono all’origine del senso di non-appartenenza e della conseguente de-responsabilizzazione dei comportamenti individuali.
Infine, la sezione ‘normativa’ (sempre con implicito rimando a una successiva fase di attuazione in sede negoziale) si conclude con l’impegno del Governo a sostenere la “graduale introduzione” nel settore pubblico di forme di welfare contrattuale simili a quelle che, già da alcuni anni, riempiono di nuova linfa vitale i contratti collettivi del settore privato, con reciproca soddisfazione di lavoratori e aziende. Si punta qui, evidentemente, a sanare la discrasia rappresentata dalla preclusione per i dipendenti pubblici delle agevolazioni fiscali sul salario di produttività, da tempo introdotte per i lavoratori delle imprese private. Una disparità che appare tanto più anacronistica in una fase, come quella attuale, in cui la politica contrattuale promossa dal Governo e dalle parti sociali appare sempre più orientata a favorire (con l’ausilio di specifici provvedimenti legislativi il cui finanziamento, com’è noto, ricade sull’intera collettività) la diffusione di meccanismi premiali correlati al raggiungimento di risultati certi e misurabili in termini di miglioramento dell’efficienza aziendale e di incremento produttivo. In questo senso, l’intesa del 30 novembre ha il grande merito di portare in primo piano il tema della condizione di arretratezza del settore pubblico nell’adozione degli strumenti di tutela del proprio capitale umano, anche per effetto della sua esclusione dal circuito virtuoso della ‘premialità produttiva’ correlata a parametri condivisi di valutazione dei risultati e sostenuta dagli incentivi posti a carico della fiscalità generale. L’importanza di natura non solo politica, ma – forse più propriamente - economico-sociale di questo passaggio è sottolineata proprio da quel rimando al welfare contrattuale (“con misure che integrano e implementano le prestazioni pubbliche”) che per la prima volta apre lo sguardo del lavoro pubblico su quella sorta di nouvelle frontière contrattualistica rappresentata dalla possibilità di sostituire, in tutto o in parte, la retribuzione di produttività (ancorché assoggettata ad aliquota sostitutiva ridotta) con benefit e prestazioni assistenziali in favore dei lavoratori e dei loro familiari, totalmente esenti da imposizione fiscale .
 Per concludere, sembra opportuno dedicare qualche breve spazio di riflessione agli aspetti di carattere economico condensati nella terza parte dell’intesa. Si tratta di contenuti sostanzialmente ormai noti al grande pubblico, in quanto illustrati dai mezzi d’informazione con dovizia di particolari sin dalle prime ore successive alla firma dell’accordo. L’impegno più eclatante ricade (ovviamente) sulle spalle del Governo e consiste nel reperimento, nell’ambito delle leggi di bilancio, di risorse finanziarie che consentano di “definire incrementi contrattuali in linea con quelli riconosciuti mediamente ai lavoratori privati e, comunque, non inferiori a 85 € mensili medi”, da intendere a regime, per il triennio 2016-2018. Va osservato che la legge di bilancio per il 2017, appena approvata dal Parlamento, prevede (art. 1, comma 364) uno stanziamento complessivo[9] “per il pubblico impiego” pari a 1.920,8 milioni di euro per il 2017 e a 2.633 milioni di euro a decorrere dal 2018. Ma non tutte queste risorse potranno essere destinate ai rinnovi contrattuali, poiché una parte di esse servirà a finanziare le nuove assunzioni di personale nei Corpi di polizia e il riordino delle carriere degli stessi Corpi, previsto dall’art. 8 della legge 124/2015. Nella legge di bilancio appena approvata, peraltro, non sono presenti riferimenti che consentano di ipotizzare una ripartizione delle somme disponibili, tuttavia il documento del 30 novembre reca l’impegno del governo ad utilizzarne “la quota prevalente per il rinnovo dei contratti” e a garantire “specifici stanziamenti” anche per quei (vasti) settori del lavoro pubblico che, contrattualmente, dipendono dagli stanziamenti ricavabili all’interno dei rispettivi bilanci.
Per concludere, sembra opportuno dedicare qualche breve spazio di riflessione agli aspetti di carattere economico condensati nella terza parte dell’intesa. Si tratta di contenuti sostanzialmente ormai noti al grande pubblico, in quanto illustrati dai mezzi d’informazione con dovizia di particolari sin dalle prime ore successive alla firma dell’accordo. L’impegno più eclatante ricade (ovviamente) sulle spalle del Governo e consiste nel reperimento, nell’ambito delle leggi di bilancio, di risorse finanziarie che consentano di “definire incrementi contrattuali in linea con quelli riconosciuti mediamente ai lavoratori privati e, comunque, non inferiori a 85 € mensili medi”, da intendere a regime, per il triennio 2016-2018. Va osservato che la legge di bilancio per il 2017, appena approvata dal Parlamento, prevede (art. 1, comma 364) uno stanziamento complessivo[9] “per il pubblico impiego” pari a 1.920,8 milioni di euro per il 2017 e a 2.633 milioni di euro a decorrere dal 2018. Ma non tutte queste risorse potranno essere destinate ai rinnovi contrattuali, poiché una parte di esse servirà a finanziare le nuove assunzioni di personale nei Corpi di polizia e il riordino delle carriere degli stessi Corpi, previsto dall’art. 8 della legge 124/2015. Nella legge di bilancio appena approvata, peraltro, non sono presenti riferimenti che consentano di ipotizzare una ripartizione delle somme disponibili, tuttavia il documento del 30 novembre reca l’impegno del governo ad utilizzarne “la quota prevalente per il rinnovo dei contratti” e a garantire “specifici stanziamenti” anche per quei (vasti) settori del lavoro pubblico che, contrattualmente, dipendono dagli stanziamenti ricavabili all’interno dei rispettivi bilanci.
Proprio la “parte economica” racchiude uno dei punti più controversi dell’intesa, la cui lettura non dissimula, anche sul piano lessicale, le tracce della faticosa e complessa discussione che l’ha preceduta. Si tratta del reciproco impegno assunto dalle parti firmatarie a garantire, in contrattazione, aumenti che riducano la forbice retributiva, principio coerente con la logica più volte esternata dal governo, nel suo ruolo di datore di lavoro pubblico, di voler “dare di più a chi ha di meno” e che qui viene in buona sostanza condivisa dalle organizzazioni sindacali firmatarie. La formulazione prescelta lascia però (e a nostro avviso non poteva essere diversamente) un margine di manovra piuttosto ampio ai tavoli negoziali: come declinare sul piano tecnico-contrattuale un principio del genere? Come impostare tabelle di progressione economica che “valorizzino prioritariamente i livelli retributivi che più hanno sofferto la crisi economica e il blocco della contrattazione”? Un problema, quest’ultimo, che incrocia direttamente quello degli effetti negativi derivanti, per molti lavoratori, dal superamento delle soglie massime di reddito a suo tempo fissate per la corresponsione del bonus di 80 euro e che riguardano proprio le buste paga meno elevate[10]. L’intesa non definisce le soluzioni tecniche per evitare che la restituzione del bonus fiscale, conseguente alla corresponsione degli aumenti contrattuali, determini un saldo negativo o, comunque, un incremento retributivo irrisorio per i lavoratori interessati. Impegna però le parti ad affrontare la questione ai tavoli negoziali, lasciando aperto (almeno per il momento) il nodo più difficile da sciogliere: quello, cioè, relativo alla quantificazione e al reperimento delle risorse. Si può presumere che qualche indicazione in merito possa arrivare dagli atti di indirizzo dei Comitati di settore all’ARAN, preventivamente sottoposti al governo, che rappresentano l’indispensabile premessa all’apertura della tornata contrattuale vera e propria.
La tenuta dell’accordo si gioca, in definitiva, sulla esatta quantificazione delle risorse ancora da reperire e basa i suoi presupposti su una sorta di patto di fiducia reciproca tra governo e parti sindacali: un patto che, a questo punto, non potrà più essere mantenuto dal governo che l’ha sottoscritto, ma che difficilmente potrà essere rinnegato dal nuovo esecutivo, insediatosi nel segno della continuità con quello che l’ha preceduto. In questo senso, lo snodo essenziale è sicuramente rappresentato dal decreto attuativo dell’art. 17 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, al quale si assegna il ruolo di principale collettore legislativo per il recepimento dei contenuti dell’intesa. Per uno strano paradosso, il ritorno al futuro del settore pubblico nella terra novamente retrovata della de-legificazione del rapporto di lavoro e della prevalenza del contratto sulla legge dovrà passare attraverso un atto la cui elaborazione (stando al dettato della legge n. 124/2015) prevede un grado di coinvolgimento delle parti sociali relativamente modesto. Anche da questo punto di vista, quindi, l’accordo del 30 novembre rappresenta un formidabile contrappeso che rimette in equilibrio un processo decisionale altrimenti asimmetrico e, per questo, poco funzionale all’obiettivo di rendere la pubblica amministrazione più vicina agli interessi e alle aspettative reali del Paese attraverso la leva del cambiamento interno. ![]()
 Note
Note
[1] Così gli articoli del codice civile richiamati:
Articolo 1339: “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.”
Articolo 1419: “La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.”
[2] Da questa considerazione resta ovviamente fuori la (peraltro non effimera) platea di dipendenti pubblici esclusi ab origine dal processo di privatizzazione del rapporto di lavoro e rientranti nelle categorie che hanno conservato il regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 165/2001: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, professori e ricercatori universitari.
[3] Per diversi aspetti, i risultati prodotti potevano ben essere considerati all’avanguardia rispetto allo stesso mondo del lavoro privato. Prima delle riforme normative introdotte dalla c.d. “Legge Biagi”, ad esempio, il sistema relazionale del settore pubblico aveva definito - pur in riferimento alle normative esistenti - importanti cornici regolatorie delle forme di lavoro flessibile finalizzate ad agevolare la diffusione di una organizzazione del lavoro più moderna, efficace e dinamica (part-time, lavoro interinale, lavoro a distanza…), mentre l’accordo quadro del 7 agosto 1998 aveva sancito l’abbandono dei vecchi strumenti di rappresentanza ‘aziendale’ basati sull’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, per adottare un sistema rappresentativo a carattere universale (RSU) in grado di assicurare la trasparenza e l’obiettività del processo di misurazione, nonché la conseguente piena legittimità giuridica degli accordi collettivi sottoscritti sia a livello nazionale che decentrato.
[4] Il fantasma della vexata quaestio concernente l’applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 150/2009 si agita, evidentemente, sullo sfondo di questo passaggio cruciale dell’intesa, che ribadisce l’intento di affermare la assoluta centralità della contrattazione nella scelta dei criteri di distribuzione selettiva dei premi in base alla produttività. Peraltro, a conferma indiretta dei limiti attuativi intrinseci alla norma brunettiana, non è mancato, anche in tempi recenti,qualche tentativo di elaborare soluzioni normative ‘autoctone’ al problema della eccessiva rigidità del sistema a tre fasce definito dall’art. 19 del d.lgs. 150/2009: come, ad esempio, il DPCM 15 giugno 2016, n. 158 (“Regolamento recante determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali”) che nell’art. 5 (“Criteri per la differenziazione delle valutazioni”) modifica l’architettura delle fasce di valutazione della performance, elevandole da tre a quattro e variando la composizione percentuale sia dei destinatari che delle risorse economiche da distribuire per ciascuna fascia. Per la cronaca, ricordiamo che tale provvedimento, del tutto eterògeno al sistema contrattuale, ancorché migliorativo rispetto al dettato originario dell’art. 19, ha subito incontrato l‘opposizione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria di CGIL, CISL e UIL, che il 25 agosto 2016 hanno formalmente diffidato l’Amministrazione finanziaria dal procedere all’adozione dei contenuti del DPCM sui criteri di distribuzione dei premi di produttività, prima che sia rimessa in moto la nuova tornata di contrattazione collettiva nazionale.
[5] Nel generale contesto di recupero dello spirito contrattualistico dei primi anni ’90 che informa di sé questa sezione dell’intesa, il paragrafo in questione può anche essere letto, in filigrana, come l’occasione storica per riesumare dall’oblìo il mai applicato articolo 44 del d.lgs. 165/2001 (ma nella sua carta d’identità originale c’era scritto art 48 del d.lgs. 29/1993): uno dei pochi ad essere sopravvissuto, intonso e quasi dimenticato, all’infinito sciame sismico di modifiche che nel corso degli anni, tra una riforma della p.a. e l’altra, ha riscritto (e non una sola volta) intere sezioni del decreto. Non quindi per solo gusto di erudizione lavoristico-sindacale ci sembra interessante, in questa sede, riproporne la lettura:
“Art. 44 - 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché' nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.”
[6] Così la prima parte della norma richiamata: “3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione”.
[7] In questa prospettiva, l’intesa reca anche un impegno correlato (per così dire) del Governo a “modificare e semplificare” il sistema dei fondi di contrattazione di secondo livello, oggi in verità alquanto farraginoso e dispersivo, al fine di consentire una più ampia fruibilità di strumenti e risorse in sede di contrattazione integrativa.
 [8] Al riguardo, è forse utile ricordare che la legge di stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto (art. 1, commi 182-191) un pacchetto di norme finalizzate al potenziamento della contrattazione di secondo livello nel settore privato, con importanti riflessi in materia di welfare aziendale. Modificando infatti il comma 2, lettera f) dell’art. 51 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), è stato previsto che le somme erogate dai datori di lavoro a seguito di accordi di contrattazione collettiva di secondo livello per finalità riconducibili a “oneri di utilità sociale” (“Educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”) non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente. La predetta agevolazione spetta anche nel caso che la contrattazione collettiva preveda la possibilità per il lavoratore di scegliere di fruire dei suddetti benefit al posto delle somme spettanti a titolo di premio di produttività ed assoggettate ad aliquota fiscale agevolata del 10%. Oltre alle finalità sopra ricordate l'esenzione IRPEF per le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti in attuazione di contratti collettivi di secondo livello può riguardare: a) la fruizione, da parte dei familiari, di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare (compresi i servizi integrativi e di mensa), per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, nonché di borse di studio; b) la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. Si prevede anche la possibilità per i datori di lavoro di erogare beni, prestazioni opere e servizi mediante voucher (“documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”). A titolo di informazione, mette conto segnalare che il decreto interministeriale Lavoro-Economia 25 marzo 2016 ha chiarito (art. 6) che i voucher devono essere nominativi, non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, né monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, opera, prestazione o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare, a meno che il valore complessivo della prestazione risulti inferiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.
[8] Al riguardo, è forse utile ricordare che la legge di stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto (art. 1, commi 182-191) un pacchetto di norme finalizzate al potenziamento della contrattazione di secondo livello nel settore privato, con importanti riflessi in materia di welfare aziendale. Modificando infatti il comma 2, lettera f) dell’art. 51 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), è stato previsto che le somme erogate dai datori di lavoro a seguito di accordi di contrattazione collettiva di secondo livello per finalità riconducibili a “oneri di utilità sociale” (“Educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”) non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente. La predetta agevolazione spetta anche nel caso che la contrattazione collettiva preveda la possibilità per il lavoratore di scegliere di fruire dei suddetti benefit al posto delle somme spettanti a titolo di premio di produttività ed assoggettate ad aliquota fiscale agevolata del 10%. Oltre alle finalità sopra ricordate l'esenzione IRPEF per le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti in attuazione di contratti collettivi di secondo livello può riguardare: a) la fruizione, da parte dei familiari, di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare (compresi i servizi integrativi e di mensa), per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, nonché di borse di studio; b) la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. Si prevede anche la possibilità per i datori di lavoro di erogare beni, prestazioni opere e servizi mediante voucher (“documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”). A titolo di informazione, mette conto segnalare che il decreto interministeriale Lavoro-Economia 25 marzo 2016 ha chiarito (art. 6) che i voucher devono essere nominativi, non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, né monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, opera, prestazione o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare, a meno che il valore complessivo della prestazione risulti inferiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.
A sua volta, l’art. 23 della legge di bilancio per il 2017, oltre ad ampliare i margini di applicabilità delle riduzioni fiscali in favore delle quote di salario accessorio erogate in corrispondenza di premi di produttività, ha esteso ad ulteriori categorie di beni e servizi, erogati in applicazione di contratti collettivi di lavoro, l’agevolazione spettante, in alternativa, a quella prevista per le somme in denaro, tra i quali rientrano anche la concessione di prestiti a tassi agevolati, nonché i contributi a strumenti di previdenza complementare o assistenza sanitaria integrativa.
[9] Gli importi indicati nel citato comma 364 includono anche le risorse per i rinnovi contrattuali già stanziate nell’ambito della legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) e non ancora utilizzate. Vi sono inoltre ricompresi gli importi di cui al successivo comma 366 (140 milioni di euro per il 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2018), concernente l’istituzione di uno speciale fondo autonomo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da destinare all’incremento degli organici degli enti di ricerca.
[10] Il riferimento, in questo caso, è al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 1: “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”. Ricordiamo che la soglia di reddito complessivo per avere diritto al bonus pieno è stata fissata in 24.000 euro annui, e che l’importo del bonus si riduce progressivamente, sino ad annullarsi del tutto, per coloro che si collocano nella fascia di reddito compresa tra 24.000 e 26.000 euro.
[*] Marco Biagiotti, ex dipendente del Ministero del Lavoro, attualmente presta servizio presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. In passato ha collaborato alla realizzazione, per la UIL Pubblica Amministrazione, della collana di volumi su “Lavoro e contratti nel pubblico impiego”. Dal 1996 al 2009 é stato responsabile del periodico di informazione e cultura sindacale “Il Corriere del Lavoro”.



Seguiteci su Facebook